
«Le immagini non sono più quelle di un tempo. Impossibile fidarsi di loro. Lo sappiamo tutti. Lo sai anche tu. Mentre noi crescevamo le immagini erano narratrici di storia e rivelatrici di cose. Ora sono tutte in vendita con le loro storie e le loro cose. Sono cambiate sotto i nostri occhi. Non sanno più come mostrare noi. Hanno dimenticato tutto. Le immagini vengono vendute al di là del mondo, Winter, e con grossi sconti. [...] Io amo davvero questa città. Lisboa… e c’è stato un tempo che io veramente l’ho vista di fronte ai miei occhi. Ma puntare una cinepresa è come puntare un fucile e ogni volta che la puntavo mi sembrava come se la vita si prosciugasse dalle cose. E io giravo, giravo, ma ad ogni colpo di manovella la città si ritraeva. Svaniva sempre di più, sempre di più. Come il gatto di Alice. Nada. Stava diventando insopportabile. Dio lo spavento che mi ha preso. A questo punto ho cercato il tuo aiuto. E per un po’ ho vissuto con l’illusione che il suono potesse salvare il giorno, che i tuoi microfoni potessero strappare le mie immagini dalle loro tenebre. No, non c’è speranza. Non c’è speranza per nulla, Winter. Non c’è speranza, Ma questa è la strada Winter e io voglio percorrerla. Ascolta. Un’immagine che non sia stata vista non può svendere nulla. È pura e perciò vera e meravigliosa. Insomma innocente. Finché nessun occhio la contamina è in perfetto unisono con il mondo. Se nessuno l’ha guardata, l’immagine e l’oggetto che rappresenta, sono uno dell’altra. Sì, una volta che l’immagine è stata vista l’oggetto che è in essa muore. Ecco, Winter, la mia biblioteca delle immagini non viste. Ognuno di questi nastri è stato girato senza che nessuno guardasse attraverso la lente, Nessuno li ha visti mentre venivano impressi. Nessuno, dopo, che li abbia controllati. Tutto quello che ho ripreso, l’ho ripreso alle mie spalle. Queste immagini mostrano la città com’è e non come vorrei che fosse. Insomma queste sono nel primo dolce sonno dell’innocenza. Pronte per essere scoperte da generazioni future con occhi diversi dai nostri. Non preoccuparti amico saremo morti da un pezzo».
Sono le parole che nel 1994 Wim Wenders fa rivolgere da Friedrich Munro all’amico Philip Winter quando lo accoglie nella sua biblioteca delle immagini mai viste, verso la fine di Lisbon Story.
Ovviamente il discorso si rivolge primariamente al ruolo del cinema e ai suoi linguaggi, ma non si fa certo una gran forzatura accoglierlo nella prospettiva delle immagini fisse. Alla base posiamo trovare la chimera della rappresentazione del reale in fotografia. Ovvero un concetto che si scontra da sempre con l’ineludibile processo di selezione operata dal fotografo tanto nella dimensione spaziale quanto in quella temporale nel momento in cui sceglie la propria inquadratura e l’istante dello scatto. La chiave di lettura di questo duplice atto è proprio la volizione implicita e determinante che disvela l’insieme dei processi di formazione cognitiva e culturale di ogni singolo individuo. In altre parole ognuno di noi è il risultato del cammino svolto nel corso della propria esistenza. Ognuno di noi compie un percorso durante il quale incontra concetti e idee che finisce per assimilare e metabolizzare in modo più o meno complesso e coerente. Tutto questo determina in noi una precisa identità culturale attraverso la quale viene filtrato il quotidiano. E sarà proprio questo filtro a fornire i codici interpretativi del reale determinando quella trascrizione iconografica che strumentalmente è determinata e definita dalla scelta dell’inquadratura e dell’istante dello scatto. In quest’ottica appare quindi impossibile pensare a un’oggettività dell’immagine fotografica, anche solo presumibile. Forse in questo sta il fascino della provocatoria tesi esposta da Wenders circa il preservare la purezza di immagini attraverso l’assenza di un’azione cosciente dell’operatore che le acquisisce e l’assenza di una visione a posteriori. Una provocazione interessante di sicuro, ma non per questo priva di ambiguità. Che succede ad esempio se proviamo a spostare il baricentro della questione su un livello di applicazione pratica come quello della documentazione iconografica di tipo giornalistico? Quale ruolo finirebbe per assumere chi materialmente effettua le riprese? Fino a che punto, pur non osservando le immagini, sarebbe in grado di non influenzarne il contenuto? A livello di mera speculazione teorica perché il processo assuma una reale valenza di purificazione delle immagini nell’accezione wenderiana, le riprese dovrebbero essere realizzate in modo completamente meccanico. Ma, in ultima analisi, perché una macchina funzioni è necessaria una programmazione di qualche tipo. Cosa questa che farebbe immediatamente porre un quesito circa il livello di influenza della programmazione sul risultato finale. E poiché allo stadio attuale della tecnologia concepibile, la programmazione sarebbe effettuata da un essere umano, ritorneremmo a chiederci fino a che punto l’uomo non influenzerebbe il risultato finale con la scelta dei parametri da applicare. Ma anche ammettendo di poter ripulire il campo da obiezioni di questo genere, si porrebbe un altro genere di problematica. Supponiamo che sia stato possibile realizzare immagini pure, sempre nell’accezione teorizzata nel film di Wenders. Supponiamo anche che giungano a un pubblico futuro, avrebbe questo gli strumenti per evitare fraintendimenti culturali derivanti dalla sovrapposizione di moduli interpretativi non coerenti con quanto rappresentato nelle immagini? Ovvero fino a che punto i modelli culturali, che si sono sviluppati nell’arco di tempo tra l’acquisizione e la visione, sarebbero in grado di interpretare correttamente le immagini? Non si deve dimenticare infatti che se l’immagine è un testo, ovvero è latrice di un messaggio, perché esista comunicazione è necessario che esista un ricevente dello stesso in grado di decodificarlo. Allo stato attuale delle cose, e prevalentemente in ottica fotogiornalistica, possiamo presumere la faziosità di un operatore dell’immagine e comportarci in conseguenza nella valutazione delle immagini. Nella valutazione si devono tenere presente il senso etico che spinge a fare determinate scelte e avere informazioni circa le posizioni dell’autore. In una teorica dimensione wenderiana il problema si sposterebbe direttamente sull’interprete con qualche problema in più derivante dallo sfasamento cronologico tra visione e acquisizione. Si potrebbe dire che in quel modo si ridurrebbe al cinquanta per cento il problema interpretativo, ma sinceramente preferisco auspicare un lavoro doppio di decodifica, in cui però si tenga primariamente conto del valore della sfera dell’etica professionale. Se penso quindi alla mesta realtà contemporanea del fotogiornalismo preferisco dover fare i conti con la conoscenza dell’autore per inquadrarne il pensiero e il lavoro, piuttosto che con l’asetticità di una ripresa meccanica di cui non sarò mai in grado di discriminare la percentuale di casualità o di determinazione aprioristica. Certo il discorso fatto da Wenders e dai suoi sceneggiatori mirava ad altri ambiti comunicativi. Ma è interessante notare come dimostri al suo interno una profonda incoerenza assoggettata alle leggi di mercato. Mentre infatti si teorizza una purezza delle immagini e si tuona contro la loro svendita, si è contemporaneamente vittime di una tempesta di product placement, ovvero di apparizioni... casuali di prodotti commerciali chiaramente identificabili. E per quanto sia comprensibile e giustificabile come fonte di finanziamento della produzione, non credo si possa dire che si tratta di immagini pure.
Sandro Iovine
n. 206 - giugno 2009
Compatibilmente con i tempi redazionali, i commenti più interessanti a questo post potranno essere pubblicati all'interno della rubrica FOTOGRAFIA: PARLIAMONE! nel numero di luglio de IL FOTOGRAFO.![]()
Puoi contribuire alla diffusione di questo post votandolo su FAI.INFORMAZIONE. Il reale numero di voti ricevuti è visibile solo nella pagina del post (clicca sul titolo o vai sui commenti).
Puoi votare le mie notizie anche in questa pagina.

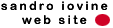

9 commenti:
Caro Iovine, pur essendo un ammiratore di Wenders (soprattutto del "Cielo sopra Berlino", una stupenda poesia in forma cinematografica), sono più d'accordo con te che con lui sul tema della contestualizzazione delle immagini. Le immagini "pure" non esistono, e mi pare difficile perfino definirle. Le immagini, come tu scrivi con altri termini, sono strumenti di comunicazione che implicano un rapporto culturale tra comunicante da un lato e ricevente, lettore, fruitore, dall'altro. Per fare un esempio di attualità, la pubblicazione delle foto appena sequestrate a quel fotografo sardo che pare abbia "colto sul fatto" un anziano signore in compagnia di diverse signorine, maggiorenni e minorenni, avrebbe avuto un senso ben chiaro per gli spettatori di oggi, data la dimensione pubblica del vecchio, data la discussione che è in corso sui "criteri", mi si passi il termine, per la selezione di parte della classe dirigente della Italia di oggi e data infine la conseguente discussione sulla degenerazione in atto della democrazia. Se quelle immagini, che nessuno ha visto, venissero viste da un pubblico molto distante nel tempo, se cioè fossero decontestualizzate, perderebbero grande parte del loro significato, ritraendo, al massimo e se fosse vera l'ipotesi, un uomo anziano con donne troppo giovani per lui, persone delle quali ci si potrà domandare, senza avere risposte, da quali rapporti di denaro o di potere siano tenute insieme, potendo ragionevolmente dubitare che si tratti di amore. E certamente, con buona pace di Wenders, quelle ipotetiche immagini potrebbero essere definite in molti modi, ma dubito che qualcuno potrebbe giudicarle "pure". Del resto, come efficacemente scrivi, e come dimostri nel servizio "Beijing 2009", sempre nel numero di giugno del Il Fotografo, lo stesso scatto di una foto implica, inevitabilmente, molte scelte comunicative non solo in relazione al tempo di esposizione o al diaframma, ma al luogo, al soggetto, al momento, al significato comunicante che l'autore vuole trasmettere ai fuitori dei suoi messaggi fotografici o cinematografici. Aggiungerei semmai questo, che non sempre esiste un rapporto diretto tra comunicatore e fruitore. Spesso è un rapporto mediato da soggetti terzi, ciascuno dei quali partecipa alla formazione del processo culturale o mediatico della comunicazione. Nell'esempio di prima, il fotografo probabilmente voleva solo fare un po' di soldi e non si poneva domande sul destino della democrazia. Se le foto fossero state acquistate da certi giornali, probabilmente non sarebbero mai state pubblicate; se acquistate da altri, sarebbero state pubblicate magari con intenti "scandalistici"; da altri ancora appunto per porre domande di più ampio respiro.
Sì, tu hai ragione e Wenders torto. E scusa se è poco. Un lettore affezionato, Giuseppe Dati
Ritengo che ogni persona che produca, o fruisca di un immagine non possa che attribuire significati propri a quanto vede. Tali significati sono filtrati dalla propria esperienza personale, dai propri vissuti e dalla rievocazione emotiva che una data rappresentazione produce in chi la osserva. Penso che ponendo dieci persone di fronte all'immagine di una sedia, ognuna avrà nei suoi confronti una visione del tutto personale derivante dall'interazione presente e passata avuta con l'oggetto in questione. Se sono caduto da una sedia e mi sono rotto un polso, la suggestione che avrò osservando la rappresentazione della sedia sarà probabilmente diversa dalla persona che ne ha appena acquistata una, o dal ricordo gradevole o spiacevole, del padre falegname che costruiva sedie ecc.
Per quanto riguarda l'articolo sulle “immagini mai viste” pubblicate nell'editoriale penso che la casualità nella produzione di un' immagine non sia possibile. La decisione di rappresentare casualmente una cosa è di per sé già una scelta che contiene una precisa intenzionalità.
Ritengo che, per quanto detto precedentemente, sia impossibile non attribuire significati propri anche ad immagini scattate/filmate casualmente, magari cinquantanni prima. L'osservatore dopo un così lungo periodo, nella sua interpretazione, sarebbe condizionato dai filtri prodotti dal proprio tempo, dalla propria conoscenza, dal proprio percorso esperienziale e da cinquantanni di storia che sicuramente avranno modificato il modo di percepire le cose e osservare le immagini.
Mi viene da pensare alle raffigurazioni rupestri che rappresentano scene di caccia (perchè prive di riferimenti grafici precedenti). Gli autori ci hanno dato la propria visione delle scene rappresentate che sono state filtrate sia dalla personale esperienza vissuta che dalla rappresentazione mentale della battuta di caccia. Sicuramente l'evento è oggettivo, ma la rappresentazione è soggettiva. Penso che la raffigurazione grafica fatta da un cacciatore ferito in una battuta di caccia e sopravvissuto all'animale, sia differente da quella di un cacciatore che non ha mai vissuto tale accadimento. Ma non è scontato che la portata emotiva sia maggiore nel cacciatore ferito rispetto a quello che invece non lo è stato.
Bruno
Trasferire sensazioni vissute nel tempo attraverso la fotografia, secondo me, comporta sempre anche in minima parte, una influenza personale di chi scatta. A meno che non si scatti per caso, ma già la scelta del luogo ne determina una non purezza, una non casualità...Io mi chiedo, invece, e se la purezza ci fosse da parte di chi "legge" l'immagine? è possibile essere puri davanti ad una immagine senza condizionarla o interpretarla solo sulla base dell'esperienza/vissuto personale?
E' possibile ascoltare l'immagine in silenzio?
Quando queste vengono distorte ed utilizzate per altri fini cade ogni discorso.
L'esempio che mostri, nasce da una purezza di intenti, che si scontra con la realtà...del resto nella vita è così, nel momento in cui ti rapporti con gli altri, necessariamente devi adeguarti per poter avere un punto di contatto, altrimenti il contatto non avviene...credo che sia così anche per la fotografia...
Un saluto
Umberto
L'immagine pura...
secondo me smette di esserlo, non appena viene vista; Ciascuno di noi, con la sua storia, la sua esperienza, i suoi pregiudizi, inquina la scena che osserva e ne dà una connotazione ed un significato personale.
Non credo che questo sia un male, anzi, la fa sua.
E questo è vero sia in fotografia, sia nella vita; l'uomo diventa impuro, contaminato non appena viene al mondo e lo diventa sempre piùman mano che fa esperienze, che acquisisce conoscenze, che si confronta e che ingloba le esperienze e le conoscenze altrui
L'immagine pura non esiste. Non se partecipata dall'uomo. Senza l'uomo l'"immagine" esiste? Non è questione di antropocentrismo. Chi vede immagini? Non lo sappiamo, oltre noi. Vedere il reale è altro. L'"immagine" esiste se (vista o meno) è ripresa (alla cieca o meno), poi vista e interpretata.
Wenders può essere così ingenuo da contraddirsi tra tesi e prassi? Non potrebbe invece mettere solo in scena, e perfettamente e quasi confidenzialmente (questo è impagabile), le "paranoie" cui il lavoro sulle immagini conduce, inevitabilmente?
Fa di più. Porta in scena la distorsione della solitudine di chi riflette sulla propria ricerca, la prende in giro, con amorevole ironia, e la risolve attraverso la prossimità con l'altro. Con l'infrazione della solitudine (e dell'ossessione). Con lo starsi accanto (l'intelligenza dello stare accanto anche di lontano attraverso lo stesso strumento che ha alimentato l'ossessione solitaria o mediata da improbabili non-vedenti, che sono solo non-sovrastrutturati).
Con l'infrazione della solitudine (e dell'ossessione). E non è l'unica volta che questo accade nei suoi racconti.
L'estetica espressa da Wenders coinvolge, forse appena suggerendolo, un tema che sin dai grandi pensatori greci arriva fino ai giorni nostri: esiste la "realtà", ovvero, per dirla in termini più moderni e a cavallo con la metafisica (un ramo del sapere umano solo apparentemente distante dal quello qui indagato), esiste il mondo senza un osservatore che lo possa "pensare", "osservare", "influenzare" o anche solo "descrivere/rappresentare", secondo un qualche linguaggio?
Certo questo porta istintivamente ad una visione del mondo strettamente antropocentrica anche se, a dire il vero, essendo noi "umani", trascendere dalla nostra condizione potrebbe essere anche solo da un punto di vista teorico, impossibile.
Ma l'idea (che qui non approfondirò, per esigenze di spazio) a mio avviso molto affascinante del "vero" che non esiste in quanto tale ma solo se "cercato" si intreccia in maniera perversamente attrattiva con l'esistenza di una molteplicità di entità che devono intervenire: "un descrittore" (il fotografo o il regista) che sceglie (scientemente! e discrezionalmente) "un linguaggio" (quello delle immagini e/o dei suoni) per "descrivere" il mondo (così come lui lo percepisce autovincolandosi al linguaggio adottato) scegliendo "quale parte del mondo" descrivere ed offrire agli "osservatori" che, come in ogni forma di comunicazione, sono soggetto attivo e non passivo.
Tornando a Wenders e all'interessante spunto proposto (anche sperimentalmente, in quel di Beijing), un tema forse meno "alto" ma non meno interessante, è quello della possibilità per un "autore" (nel senso più ampio del termine) di utilizzare uno strumento in maniera del tutto asettica e "pura", in modo da dare all'osservatore la massima libertà interpretativa: esiste uno strumento che lo permetta? Anche su questo tema son stati spesi fiumi di inchiostro (personalmente mi trovo a condividere l'espressione "Non esiste tabula rasa"), e non mi azzardo minimamente ad affrontare un tema altrettanto ostico del primo, se non per dire che come l'osservatore mette "tutta la sua vita" (conscia e inconscia) in qualunque sua attività, così a maggior ragione il "descrittore" propone una serie di pre-selezioni del mondo secondo il proprio sentire/essere: ma sta proprio in questo, credo, la sottile differenza tra "immortalare" e "rappresentare" il mondo (e questo fa la differenza tra un autore mediocre ed un grande maestro).
Certo, ormai saremmo molto vicini alla costruzione di un automa automatizzato e completamente casuale (addirittura, autoassemblante), portando alle estreme conseguenze l'intederminazione indissolubilmente incorporata nella fisica sub-atomica (come già previsto da Einstain, ma dallo stesso rifiutato, asserendo che "Dio non gioca a dadi"), ma sarebbe davvero auspicabile o anche solo "utile" (se mi si passa il termine, che a sua volta comporterebbe profonde implicazioni) un tale strumento?
E spostassimo il prisma interpretativo, riducendo il dover essere di una registrazione iconografica a fatto meramente voluttario...? Se tornassimo a concepire l'immagine nulla più che come un inessenziale, o smettessimo di credere a quelle follie utopiche che invalidano la possibilità di meglio definire un qui percorribile...? Ossia, se lasciassimo il credere che sia possibile generare un non auspicabile grado zero, se smettessimo la veste del censore stupito dalle faziose dipendenze dell'interpretazione per considerarle una forma inalienabile dell' essere uomo...? Siamo fiere contaminate, meglio: la nostra purezza giace in un dove che non si suole ammettere, che non vogliamo riconoscere pena il bisogno di rifondare l'intero impianto assiologico che regge le nostre conduzioni.
Dal che mi dico che, tutto diviene legittimo, che un immagine prodotta vive libera da ceppi o vincoli, che partecipando del tutto non è più vittima di una forzatura semantica foss'anche quella dell'autore, fatti salvi i famosi diritti, perché non esistono forzature quando l'uno legge sé. La comunicazione, per quanto ragionata, teorizzata, canonizzata, cede il passo alla forza penetrativa di taluni fattori, che lungi dal porsi problemi di ordine fattuale ne hanno generato la potenza. Comunicare e speculare su ciò che comunicazione sia, sono forme non apparentabili; e sovente, mentre i dotti siedono i loro scranni credendo di poter regolare il mondo, un qualche tiranno, più o meno illuminato, quel mondo se l'è già preso. Al fondo di questa sesquipedale esplosione di umori decomposti, rimane un unica dicibile chiosa: che non ha senso genrare un 'simulacro' del reale se questo simulacro deve restare perduto nell'inveduto: se il mondo potesse rispondere, se ne fregherebbe di una lettura analogica o digitale delle sue vesti, il mondo non cerca un ricordo di se, è l'uomo: fragile, transeunte, caduco, deciduo ad abbisognare di un modo perché il tempo possa essere uno sconfitto. E l'uomo legge arbitrariamente, concorrendo alla scrittura di ciò che corre sotto il suo vedere. Eppoi, pensate le immagini come fossero un corpo: un corpo viene vissuto, transitato, deformato. Non possiamo chiedere ad unimmagine di essere viva e di perdere la sua pressante statura polisemica. Forse la mia presenza si fa niciana, forse credo che non si debbano più tutelare le masse dall'avvento deformante dei 'grandi strateghi della nostra clepto-plutocrazia', perché l'atto stesso che cerca di tutelarne l'offesa è una minaccia per quel sistema libertario e tollerante che si prefigge di proteggere. Forse le immagini liberano dal giogo non in virtù del loro senso, ma del loro numero; ed allora, smettere di generare e vedere, significherebbe abdicare all'informante statuto umano. Dal che: le immagini siano: siano libere, libere di vivere, di morire, di mutarsi; siano libere di somigliare a se stesse, di amare ogni amante che si versi al loro cospetto.
E se tutto questo inutile cadere suona spezzato, se il corsivo incedere della penna non ha la compostezza dovuta, se si riduce al coacervo vagamente abborracciato di un qualche magro aforisma, beh...forse l'intento è stato giunto. Perché quello che rimarrà delle immagini, non saranno ordinate 'iconoteche', ma solo frammenti proni ad ogni uso; rimarrà solo il claudicare di una sintassi decomposta che costruirà, sul legittimo arbitrio di un interprete, una nuova cultura. Quel che noi abbiamo fatto. E non mi si dica che tutto rimarrà. Tutto si sgretola. Risponderei: rileggete Robinson Jeffers. Se l'uomo è il fine, l'immagine ha il dovere di essere mobile. Al diletto Wenders direi, con il rispetto dovuto all'uomo che libero genera i propri pensieri: gesuitiche fanfaluche di un qualche debole che scaglia sul mondo le proprie paure. Il mondo non ha paura. Il mondo se ne frega. Il mondo è magicamente intransitivo. E'. Lasciamo che le immagini siano la stessa cosa. Siano.
Vedendo il film Lisbon Story, e in particolare la sequenza che hai analizzato nel tuo editoriale, la mia attenzione non è andata tanto al punto se sia veramente possibile produrre immagini "pure" o no (a questo riguardo sono d’accordo con la tua analisi), quanto a un'altra questione che ritengo, purtroppo, sempre più attuale: l'assoluta necessità di avere qualcosa da raccontare quando si scatta una fotografia, si scrive un libro, una canzone, un articolo, si gira un film, si dipinge un quadro, ecc.
Sempre più spesso si producono immagini che non dicono nulla perché nulla hanno da dire. Il discorso si può tranquillamente estendere a tutte le altre attività umane, in quanto mai come oggi siamo immersi in una società che ti spinge a fare, produrre, correre senza mai voltarti e soprattutto senza mai porti delle domande e dove risulta sempre più difficile cogliere l’essenza delle azioni intraprese. La scena delle “immagini mai viste” è significativa, a mio parere, in quanto parla della rinuncia alla consapevolezza della ripresa da parte di Munro nel tentativo di ritrovare il collegamento perduto tra le proprie emozioni e le immagini impresse sulla pellicola. Egli arriva a sentire la necessità di un estraniazione e un isolamento totale dalla società, per ritrovare dentro di sè gli stimoli primordiali che portano alcuni di noi a osservare con un’intensità particolare tutto quello che ci appare davanti, a voler comprendere e conseguentemente raccontare ciò che ci circonda. Tanto più che alla fine Friedrich Munro si butta nuovamente nelle strade di quel quadro a cielo aperto che è la città di Lisbona e cerca di coglierne, con piena consapevolezza, gli aspetti e le sfumature che intende regalare ai propri spettatori grazie alla pellicola.
Ho sempre pensato che tutto l’insieme dei processi di formazione cognitiva e culturale di ogni singolo individuo, ovvero tutto il vasto insieme delle esperienze vissute direttamente o indirettamente da ognuno di noi nel nostro processo/vita, contribuisse in modo primario e assolutamente indiscutibile alla creazione dei nostri lavori, in questo caso delle nostre immagini fotografiche.
Di conseguenza condivido pienamente che nella corretta valutazione di un lavoro “[…] si deve tenere presente il senso etico che spinge a fare determinate scelte e avere informazioni circa le posizioni dell’autore”.
Detto ciò, credo comunque che Wenders avesse ben chiara l’insostenibilità e la totale utopia di quanto affermato, dal suo personaggio, sulle "immagini pure".
A mio avviso ne è la prova il fatto che, nella sequenza che precede quella citata vi è una chiara distinzione dei "ruoli" (sempre che "ruoli" sia il termine adatto). Infatti, nello spazio antistante il teatro, sotto la luce del sole i due amici "casualmente" si incontrano; agli occhi di Winter, e credo anche degli spettatori, l’amico appare confuso e turbato: da settimane vaga per le strade di Lisbona senza far ritorno a casa, la stessa casa dove Winter lo ha aspettato per giorni per girare il suo film, come d’accordo, senza mai vederlo tornare. Secondo me quest’incontro serve a delineare delle chiare caratteristiche individuali dei personaggi, all’interno di uno scenario in cui vengono attribuiti equilibrio e razionalità a uno, e instabilità, irrazionalità e, diciamolo pure, un pizzico di follia all’altro; e prepara lo spettatore al discorso che, poco dopo, verrà fatto sulle immagini pure. Ne deriva, come asserito da qualcuno nei commenti precedenti, che probabilmente Wenders volesse solo “mettere in scena le paranoie cui il lavoro sulle immagini conduce inevitabilmente”. Possibile?
Posta un commento